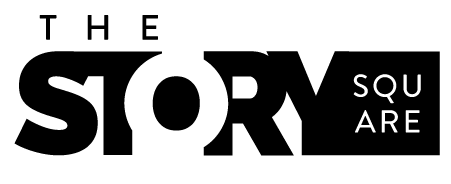La velocità, l’ossessione di cui l’essere umano è vittima, ciò che negli anni ha generato anche il suo contrario, un elogio alla lentezza di cui una certa letteratura e un certo cinema si sono fatti carico, che sia con un romanzo come quello di Kundera, omaggio alla lentezza già dal titolo, o che sia un modo di raccontare una storia sul grande schermo come fa Paolo Sorrentino, tanto per non allontanarci troppo dall’Italia.
E si badi bene che questo non è l’inizio di una filippica nostalgica contraria a tutto ciò che di nuovo viene fatto al mondo, anzi: ben venga accorciare i tempi per semplificarci la vita.
Il problema è che l’ossessione – in quanto tale – è cieca, e se da un lato è il motore per conquistare qualcosa, dall’altro si assorbe così tanto alla pelle da diventare uno schema mentale abitudinario.
L’ossessione per la velocità ha trasformato il mondo in un mondo all’avanguardia, ma non lo ha fatto senza compromessi: ha portato in cambio la trasmissione dell’ansia perenne, della corsa sempre e comunque, del cervello in rotazione senza sosta, tutti piccoli patti col diavolo in onore della velocità.
Il tempo che abbiamo risparmiato scoprendo tecnologie all’avanguardia lo abbiamo spesso riempito con un tempo ticchettato che ci dice che c’è sempre una scadenza, che c’è sempre da correre, da scappare.
Da chi si scappa? E chi lo sa, ma intanto tu scappa, ci viene sempre da pensare.
Perché è scomparso il piacere della lentezza? […] Guardo nello specchietto retrovisore: sempre la stessa macchina che non riesce a superarmi a causa del traffico in senso inverso. Accanto al guidatore è seduta una donna: perché l’uomo non le racconta qualcosa di divertente? Perché non le appoggia la mano sul ginocchio?
Macché: l’uomo maledice l’automobilista davanti a lui perché va troppo piano, e neppure la donna pensa a toccarlo con la mano, mentalmente sta guidando anche lei, e anche lei mi maledice.
Kundera scrive una scena in cui non è difficile immedesimarsi; quante occasioni di dire o fare qualcosa abbiamo sprecato in auto, in fila, troppo nervosi per accettare che la velocità di quella porzione di mondo stesse diminuendo al di sotto della nostra soglia?
Quante volte usiamo la lentezza come metro di misura per contestare un film, abituati come siamo a pretendere tremila immagini al secondo, tremila azioni, tremila di tutto?
E quante volte dimentichiamo che la lentezza può essere un valore aggiunto perché dilata gli spazi, dilata il tempo stesso e ci aiuterebbe a stare più dentro le cose, a godercele, a renderle indimenticabili? Ciò che è rapido sosta troppo poco nel cervello, ciò che si sviluppa con calma spesso resta persino sotto forma di odore, di sensazione, come una Madeleine di Proust.
Ci si può educare alla lentezza, però, e non c’è niente di meglio che educarsi con un’esperienza pratica.

Esperienza al Castello di Monte Vibiano
In Umbria c’è un luogo abitato da diciotto persone che si chiama Monte Vibiano, all’interno del quale c’è un castello; detta così può sembrare un’imitazione scialba e un po’ cliché di alcune fiabe per bambini, ma il posto esiste ed è per eccellenza quello in cui si può imparare a controllare il tempo, o almeno a fermarlo per qualche ora.
L’ossessione per la velocità di cui parlavamo è quella che porta le persone nella quotidianità a non rispettare neanche i propri tempi pur di adattarsi a quelli degli altri; nel Castello di Monte Vibiano il tour inizia con una bici elettrica a pedalata assistita che ti permette di sentire solo la fatica che scegli di voler sentire, e solo questo piccolo dettaglio restituisce simbolicamente l’idea di un’esperienza creata su misura. È lo stesso luogo per tutti, ma ognuno può trovare autonomamente quello che cerca.
Il Castello è famoso per la produzione di vino e olio, e questo fa sì che ogni pedalata serva a fondersi con un micro-mondo fatto di vigneti e di ulivi, di verde, e di tempo che sembra incastonato nei sentieri panoramici davanti ai quali sedersi e aspettare il tramonto, senza che nessuna parte di te chieda al sole di scendere in fretta.
A Monte Vibiano non esistono rumori, ma suoni; suoni leggeri della natura e storie che le guide del castello raccontano ai visitatori: perché quel vino si chiama così? Perché è così speciale l’uomo che lavora al frantoio? Qual è la vita delle persone che curano un posto magico? Chi c’era quattrocento anni fa con quell’albero di ulivo?
Quando i suoni si fanno più flebili e quando le storie sono state già raccontate, arriva il tramonto, e insieme a lui scende il silenzio. È uno di quei silenzi a cui ambisce Mia Wallace nel capolavoro Pulp di Tarantino: trovare qualcuno con cui chiudere la bocca e non sentirsi a disagio. A un certo punto a Monte Vibiano basta solo la sua bellezza per rallentare ancora di più i battiti e portare le persone che vengono per la prima volta a godere della meraviglia e perdersi in un posto in cui è facile sentirsi al sicuro, lontani dai problemi.

Per un pomeriggio assomiglia al posto della salvezza, ed è questo quello che rimane di un’esperienza simile: non tanto quello che vedi attorno, ma una sensazione che si incunea fisicamente nel corpo, scioglie i nervi più tesi ed è capace di portare lontano i pesi che ognuno di noi ha sulle spalle; chi viene a Monte Vibiano di solito socchiude gli occhi nel momento della degustazione con un calice in mano, e il vino se lo beve lentamente; cerca in tutti i modi di prolungare il momento e rinviare i saluti, di spostare quasi con le mani l’idea del ritorno al rumore.
È lì che arriva quella sensazione che suggerisce quanto ne sia valsa la pena esserci stati, e quanto impagabile sia per un giorno rompere il tempo e fondersi con quello della natura; c’è qualcosa di sacro persino nell’aria, e ne basta una boccata per rubarne definitivamente la sensazione; di tanto in tanto è dolce risentirla anche quando il rumore torna a essere tanto, per strada c’è traffico e il sorpasso a una macchina lenta può aspettare: c’è una mano da mettere sulle ginocchia di una donna, e un’altra storia da raccontare.